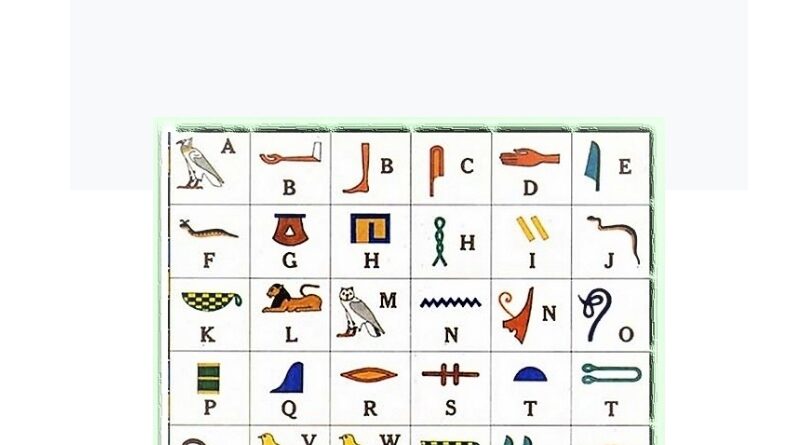IBN HAMDIS E ROSA A BEDDA O CANALI A SANTU PIETRU – Fiaba di Rocambole S. P. Garufi

IBN HAMDIS E ROSA A BEDDA O CANALI A SANTU PIETRU
Fiaba di Rocambole Garufi

Non sono molti, ma ci sono, quelli che di notte, lento pede, vanno sognando Capri o Taormina nei carruggi di Santu Pietru, il quartiere vecchio della Bellicosa Firenze degli Iblei.
Ancor di meno sono quelli che, verso la mezzanotte (l’ora canonica dei fantasmi) hanno potuto ascoltare Mariano Campo (meglio noto come Coricuntentu) che fischia le sue immortali melodie. Come era accaduto a Lucrezio Caro, lo scrittore pazzo che aveva studiato la filosofia di Epicuro.
In quell’occasione la musica di Mariano si accompagnò ai versi di Rosa A bedda o canali, che era tornata nel mondo dei vivi, sotto le sembianze di un cane nero e cieco, ed abitava sulle scale davanti alla Locanda del Sogno Antico…
Su ghiti nto quarteri di San Petru,
nfacci a crèsia, na strata ca va a scìnniri,
nun fati casu o fètu ca si senta,
pirchì, vicinu i pèzzi di miseria,
ci sta na casa mezza sdurrubbata,
ci sta un balcuni vasciu, scurciatazzu;
ma ca s’appoia ntesta a nu cagnòlu
ca pi valuri batta nu tesoru.
Porta u cagnolu a facci e Marastella,
ca fìcia nta na notti di vilenu
u povuru Turiddu, ’mmèzzu u chiàntu!
A facci è bedda, tantu ca succeda
ca quannu a luna cala, nto ghiurnari,
parissa ca du soru si salutunu!
A dispetto del nome, Rosa A Bedda o canali non era bella, ma di petto portava la quinta ed aveva lunghi riccioli neri, tra i quali tralucevano due boccoli d’oro.
Cantava le sue canzoni nella Locanda del Sogno Antico, aperta dal padre, che prima di diventare oste, fece il carrettiere, finché, pieno come un otre, cadde in un fosso nei pressi di Ponte Boria, comune di Calatabiano.
Il marito era chiamato da tutti don Pepè Coscistorti, perché nessuno ne ricordava il cognome.
E fu proprio lui che in una mitica notte di dicembre se ne tornava a casa col cuore nello zucchero, perché teneva in mano il suo bottiglione ormai quasi svuotato.
Accanto a lui c’era uno scappellino innamorato, Turiddu Papuzza, che, però, contento non era.
“Non te la scordare una nottata come questa!” disse don Pepè. “Poco fa sono arrivato fino al Lembasi e sull’altra riva ho visto un milione di lucine fra i rovi.”
Turiddu guardò significativamente il bottiglione in mano a don Pepè.
“No, non è stato il vino!” esclamò l’uomo, fermandosi di botto, un po’ risentito. “Quando sono ’mbriaco vedo cose che non ci sono… Invece, ho perfettamente riconosciuto Mariano Coricuntentu in mezzo a quelle luci-picurare.”
Turiddu fece spallucce e tornò ai suoi pensieri.
Don Pepè lo squadrò con aria preoccupata.
Poi, decise di far finta di niente e riprese a camminare.
“Sembrava che le stelle fossero scese in terra…” riprese. “A far festa, perché fischiavano e cantavano.”
“Lucciole erano, non cristiani! E non fischiavano… Forse tirava un pochettino assai di vento” borbottò Turiddu.
“Tu sei come San Tommaso! Se non tocchi, non credi.”
Don Pepè tirò un sorso dal bottiglione e si passò la lingua agli angoli della bocca.
“Eppoi, che vento ci poteva essere?” ricominciò. “Scendeva la neve e copriva i campi… eppure, per miracolo di Natale, si sono risvegliate le lucciole.”
“Eh, mastro!” esclamò allora Turiddu, mettendoglisi davanti. “Lo scuro, io ce l’ho qua! Nel cuore! Se almeno Marastella mi guardasse un po’!”
“E parlale! Vedi che risponde… Bocca che non parla si chiama cocuzza!”
“E che le debbo dire? Marastella è la più bella del paese!”
Don Pepè scansò il giovanotto con la mano e riprese la sua strada. “Ma tu brutto non sei! Parlale, che ti costa?”
“A lei non mancano i buoni partiti… Ora la cerca pure il barone don Antonio Barresi.”
“Ma, don Antonino è già sposato e, in ogni caso, con lei non si sposerebbe! Quella è gente che piglia, ma non dà.”
“E, a questo punto, io che le posso dare? Non ho manco un laccio per impiccarmi!”
“Hai gioventù e cuore di poeta… Ti pare poco?”
“A me no… ma decide lei!”
“Allora, lasciala perdere. Se preferisce un vecchio di cinquant’anni e passa solo perché è barone… è meglio che te la scordi, una così!”
“E come faccio? Per scordarla dovrei uccidermi e se non me la scordo mi ammazzo per amore!”
“Minchia, se non siete complicati, gli innamorati!”
Gli batté affettuosamente la mano sulla spalla. Poi ebbe un pensiero e scoppiò a ridere. “Sai che ti dico? Ammazzati subito e non ci pensare più!”
“Ah, no! Vossignorìa la fa troppo facile… Se mi ammazzo, come faccio ad amare Marastella?”
“Straminchia! Questa proprio non l’ho capita!”
“E non potete capirla, mastro… questione d’età! Vossignorìa, con tutto il rispetto, la bella gioventù se la scordò.”
Don Pepè alzò minacciosamente il bottiglione.
“Maleducato!” disse. “Vuoi vedere che ti ammaz-zo io e la chiudiamo qui?”
Così, parlando parlando, arrivarono davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo, un edificio massiccio che pendeva sul ciglio di uno sbalanco, in fondo al quale alcune casette si avviavano per la strada che portava alla fontana di San Vito, posta nella piazza centrale del paese.
Dalla porta della Locanda del Sogno Antico, all’angolo di fronte alla chiesa, uscì Rosa A bedda o canali, ormai prossima ai trent’anni.
Era tutta agitata, con le mani nei capelli neri e ricci ed il grembiule arrotolato sopra le sue curve spettacolari.
“Pepè, Pepè! Sono arrivati i Re Magi!” urlò.
“Eccola! Ci mancava anche questa per farla completa!” esclamò don Pepè. “Io almeno ho bevuto…”
“Li ho sistemati di sopra. Quei loro curiosi cavalli gobbi, invece, li ho fatti mettere nella stalla del cortile.”
“Cammelli, Rosettuccia mia! Si chiamano cammelli!”
Si volse a Turiddu e lo prese affettuosamente per un braccio. “O sono dromedari?”
“Dipende da quante gobbe hanno” rispose Turiddu.
“Una” disse Rosa. “Tutti i gobbi… una gobba sola tengono!”
“Saranno dromedari…” disse don Pepè.
Tornò a guardare Turiddu, con aria inquisitoria. “O sono cammelli?”
“Sono l’altra cosa che hai detto” disse Rosa. “Giammelli non sono di sicuro. I giammelli sono i bi-scotti che faccio e che piacciono tanto ai nostri clienti… Che c’entrano i giammelli con i cavalli gobbi?”
“Appunto!” sospirò don Pepè alla moglie. “Ora dimmi: quanto vino ti sei scolato?”
“E certo! Arrivano tre scimuniti con tre cavalli gobbi e la ’mbriaca sono io!”
“Lascia perdere, chiamali come vuoi dromeda… camme…, cavalli gobbi… o quel che sono! Ma, dimmi la verità, almeno: non avrai aperto la botte nuova?”
“Cavalli gobbi devi chiamarli… perché cavalli gobbi sono!”
“Addio, l’ha aperta…”
“Un bicchiere, per farlo tastare a compare Nicola…”
“E ti pareva! Si possono vedere questi tuoi cavalli gobbi?”
Rosa si mise avanti e andarono tutti fino alla stalla.
Aprirono. Don Pepè entrò con la lucerna in mano e vide tre dromedari che lo guardavano, con un fremito alle labbra, che assomigliava ad una sghignazzata.
“Minchia!” esclamò il poveretto. “Questi sono proprio cammelli!”
Uno degli animali gli si avvicinò e gli sputò in faccia.
“Minchia!” ripetè don Pepè, col carbone acceso negli occhi. “E sono pure villani!”
“Vero, anche a compare Nicola hanno sputato!” esclamò Rosa. “Mi dimenticavo di dirtelo: sputano come te, quando sei ’mbriaco.”
“Ed io li scanno e ne faccio un arrusta e mangia, loro e compare Nicola!” disse don Pepè.
“Geloso?” chiese Turiddu.
“No, difendo il mio vino!”
“Non ci pensare a toccarli!” esclamò Rosa. “I loro padroni mi hanno dato un bel sacchetto di monete d’argento.”
A don Pepè tintinnarono gli occhi e l’aria truce si fece bonaria.
“Non vi scanno più” comunicò amorevolmente alla bestia che gli aveva sputato, accarezzandole la testa. Poi, si volse alla moglie. “Cosa hai preparato per i loro padroni?”
“Pasta col macco, cocuzza d’inverno fritta con le olive nere, scacciata con segale e cipolla fritta, un bel pezzo di formaggio della Nicchiara, acqua della Zizza e, purtroppo, non hanno voluto quel vino nero nero della Varanna che comprammo il mese scorso da compare Janni… Fatto di religione, mi dissero!”
“Se non muoiono stanotte, questi sono davvero i Re Magi!” commentò Turiddu.
Don Pepè guardò Turiddu e dopo guardò in aria, come a riacchiappare un pensiero che voleva scapparsene.
Quindi, prese il giovane per un braccio. “Abbiamo trovato il sistema per aggiustare la tua faccenda…”
“Volesse Dio!” guaì Turiddu.
“Lo vuole, lo vuole!” si impose Rosa, che non aveva capito, ma tanto si intrometteva lo stesso. “Sennò perché sarebbero venuti i Re Magi a San Pietro?”
I tre arabi si trovavano in viaggio di piacere, dato che per loro la Sicilia comportava delle suggestioni che nessuna altra terra del Mediterraneo (e, conseguentemente, allora, del mondo) poteva dare.
Uno dei tre, infatti, discendeva da un poeta nato nell’isola, autore di una raccolta lirica piena di nostalgia per un passato irrimediabilmente perduto.
Era tanto orgoglioso del suo avo da averne preso il nome. O forse si faceva chiamare così perché, dei tre, soltanto lui era a San Pietro in incognito. Gli altri due avevano dei lasciapassare speciali. Fra l’altro, erano tutti ottimi e spavaldi spadaccini e non mostravano di temere nulla.
In verità, non si è mai saputo il vero motivo di quel passaggio. Ma ciò conta poco, ai fini della comprensione della storia.
Si erano seduti nella piccola sala della Locanda del Sogno Antico, gustando con ogni evidenza il cibo servito da Rosa.
Sul finire della cena entrarono don Pepè e Turiddu.
“Eppoi…” disse Turiddu sulla soglia, all’orecchio di don Pepè, il più piano che sapeva. “Vallo a capire chi ce li ha portati, ‘sti turchi, in un posto tanto scognito.”
“La stella cometa!” disse Rosa, subito vicino a loro, all’orecchio di don Pepè, il più piano che sapeva.
“Io dico che sono dei briganti e che stanno scappando” disse don Pepè, il più piano che sapeva.
“Ci ha portati qui semplicemente la neve” tagliò corto Ibn Hamdis, il discendente del poeta, che aveva sentito tutto, ridendoci sopra. “Non potevamo passare la notte fuori… non con questo freddo!”
“Uomo senza fede e senza cervello!” disse don Pepè a Turiddu. “Non lo hai capito che, stella o neve, questi signori sono qui per te?”
Rosa, invece, cominciò a pensare ai primi versi da scrivere, perché lei, come già si sa, era una cantastorie.
Taliati stu carusu ’nnamuratu,
pirchì u primu miraculu di Diu
fu dàrici cunuortu po duluri
ca Marastella ci chiantàu ’nto cori!
Si pìgghia l’omu tanti di ddi peni!
Scerra pi sordi, sòcira e politica.
Ma, si pi còlliri si po muriri,
senza l’amuri nun si po campari!
Ora Turiddu parra cu i re Magi,
ci cunta i làstimi e dumanna aiutu.
A Betlem u scuta u Bambineddu
e iddu sulu u sapi chi s’a ffari!
Si pigghia l’omu tanti di ddi peni!
Scerra pi sordi, sòcira e politica.
Ma, si pi còlliri si po muriri,
senza l’amuri nun si po campari!
“Datemi aiuto!” disse Turiddu ai tre. “Per favore! Voi siete maghi e re. Se ce la volete, una spintarella per farmi contento me la potete dare…”
Ibn Hamdis scoppiò a ridere. Poi, si rivolse ai compagni. “Come vedete, noi siciliani, anche quando siamo innamorati cerchiamo la raccomandazione!”
Don Pepè sgranò gli occhi. “Minchia! E come l’avete capito che Turiddu è innamorato?”
“Non vi ci vedo, a voi, vecchio brontolone come siete, a parlare con un mago… se non per chiedergli di moltiplicare i soldi.”
Dopo accennò con la testa a Turiddu. ”Invece, vedo questo giovane scioccherellone correre dietro le gonnelle di una ragazzina.”
Guardò significativamente Rosa. “Io preferirei una vera donna.”
“Ah!” fece don Pepè.
“Io non ci ho capito niente” mentì Rosa, tutta contenta.
“Che ci ha detto?” chiese Turiddu a don Pepè. “Parole d’offesa?”
“E che minchia ne so!” concluse don Pepè.
“Dimmi che t’è successo, figliuolo!” chiese Ibn Hamdis, che cominciava a divertirsi.
Strizzò l’occhio a Rosa e prese una positura esageratamente solenne, sforzandosi di non ridere.
Gli altri due, al contrario, ridevano senza ritegno.
“Mi chiamo Turiddu” disse Turiddu. “Ed un capriccioso destino mi volle figlio di don Cicciu Pisciacori, il calzolaio. In tutta la mia vita, mio padre me lo ricordo sempre mentre faceva sì con la testa e mentre tutti lo minacciavano, perché era il muro basso del paese… Chi voleva scavalcare… scavalcava!”
“Poveretto!” commentò Ibn Hamdis, fattosi serio.
“Altro non fece, mio padre, per tutta la sua vita, tranne alla fine, quando, anzicché sul suo cuore, cominciò a pisciare nel letto. Ma, anche in quegli ultimi giorni continuò ad abbassare la testa. Per una vita se n’era stato zitto, chino sul suo lavoro, e riusciva ad abbassare la testa anche così. Specialmente quando passava il suo padrone, don Antonino, che, fra l’altro, pare che si scapricciasse con mia madre, ogni volta che lei andava a lavare i panni al Lembasi. Io, mio padre, me lo terrò eternamente dentro con la schiena curva, quando lavorava lungo il muro della chiesa del Purgatorio e sembrava un bassorilievo. Sopra gli stava il castello di don Antonino, senza mai un sorriso per lui, se non di sfottimento!”
“Che popolo incivile!” commentò rabbuiato uno dei compagni di Ibn Hamdis.
“Ma come fa a capirti questo povero Re Maggio?” si spazientì, invece, don Pepè. “Che c’entrano con Marastella tuo padre, il barone, il castello?”
“Avete ragione!” ammise Turiddu. Poi, si volse a Ibn Hamdis. “Per voi, c’entrano?”
“Per me, sì” disse Ibn Hamdis, rispettosamente. “O, forse, c’entrano con Marastella.”
“A questa mia vita Marastella ha regalato i colori” disse Turiddu. “Marastella è povera ed abita qui di fronte, poco oltre la chiesa, in una casetta tutta storta, smozzicata e col tetto di canne. Forse non può neppure dirsi una casa, ma quattro muri scorticati. Però, lì dentro c’è il tesoro più prezioso! Marastella è così bella, che al suo fianco anche il castello del barone sembra una stalla. I suoi occhi fanno cantare il buio e quando lei ride il buio diventa sole, ed il sole diventa buio se lei è lontana, ed io ho sempre una smania dentro il cuore, una premura che squaglia ogni paura, ogni rancore, ogni ricordo più brutto…”
“Tutto il mondo è paese!” disse il compagno di Ibn Hamdis, rischiarendosi in un sorriso.
“Padre, Figlio e Spirito Santo!” esclamò don Pepè. “Di tutte le malattie questa è la più grave! Che c’è di peggio della… femmina?”
“Che ha di brutto la femmina?” chiese Ibn Hamdis.
“Purtroppo, eccellenza” rispose don Pepè, “ogni età ha i suoi punti deboli e la femmina è la croce della gioventù.”
Turiddu si inginocchiò davanti a Ibn Hamdis.
“Padrone” disse piangendo, ”con voi non ho vergogna di inginocchiarmi. Re Maggio o no, fatemela voi la grazia di parlare con qualcuno per la faccenda di Marastella! Io ho intenzioni oneste e voglio crescere una famiglia devota ai comandamenti di Santa Romana Chie-sa.”
In altra occasione la risposta per Turiddu da parte di Ibn Hamdis sarebbe stato un buon colpo di scimitarra. Ma, quella sera il poeta era troppo commosso. Perciò, per aiutare il giovane, improvvisò dei versi:
Quando giace nascosto nella terra,
l’oro non ha bellezza, o pregio d’arte.
Ma, nella luce è luce che si parte
per rendere più bella la più bella!
Turiddu, interdetto, guardò don Pepè. “Che ha detto?”
Don Pepè guardò Ibn Hamdis. “Che avete detto?”
“Da anni cerco il Re” disse Ibn Hamdis. “Vorrei portargli l’omaggio dell’oro, che non ha luce, finché resta sottoterra.”
“Quest’uomo parla come scrivono i dottori” commentò Turiddu.
“Io, invece, l’ho capito” disse Rosa. “Sua eccellenza ha detto che ci vuole un bel regalo, se davvero Marastella è la tua regina.”
“E come faccio, che non possiedo niente?” si scoraggiò Turiddu.
“Come fecero gli antichi!” sentenziò Ibn Hamdis. “Cerca ciò che vuoi.”
Quel che seguì lo raccontò poi Rosa, coi suoi versi:
E si nni jivu Turiddu a ddu cumannu
circannu na cullana pa sa bedda.
tutta a nuttata stesa caminannu
e da nuttata ficia canuscenza,
scutannu certi scrusci mai sintuti.
Sintìu vulari a sciùscio a scura pìula,
passarru tri cunigghia ca ballàvunu,
scappàvunu se’ surgia ne purtusa,
chiancìvunu du’ jatti ’nnamurati.
Passàu di Càddiri e ci furru i cani
do picuraru pronti a muzzicari,
‘cchianàu pi Santa Cruci petri petri
finu a sutta Minìu e potta truvari
un funnu di panaru sfilazzatu…
Sfunnannulu ni fìcia na cullana
e turnàu ne Re Maggi, p’àutru aiutu.
“Solo un fondo sfondato di cesta ho trovato!” disse, al mattino, Turiddu Papuzza a don Pepè, la mattina dopo, di ritorno dalla campagna.
Il mastro si era svegliato con la storta e si era affacciato alla porta della Locanda del Sogno antico, con un rosario di minchia! in bocca ed in mano una mezza bottiglia del vino nuovo di compare Janni, preso da una botte in cui ormai, grazie alle furtive visite di Rosa e di don Nicola, mancava un bel po’ di pieno e non mancava un bel po’ di vuoto.
“Ah, malasorti a mmia!” rantolò Turiddu. “Perché non ho trovato l’oro?”
Don Pepè bevve. “E tu con un culo di cesta ti vuoi pappare la più bella del paese? Hai chiesto niente!”
Nel frattempo anche Rosa era comparsa sull’uscio, con una scopa in mano, che teneva con la solennità con cui si tiene uno scettro. “Prendi buono per te, Pepè. Queste, ad un materialone come te, sembrano quattro misere verghe intrecciate… Ma, per l’uomo innamorato, le cose preziose stanno nei suoi occhi.”
Si avvicinò a Turiddu e gli poggiò le mani sulle spalle, facendolo voltare a guardare verso la casetta di Marastella. “Piuttosto, vediamo che ti dice lei. Sta venendo qua.”
Turiddu andò incontro alla ragazza. “Non c’è cosa al mondo più bella della tua bellezza. Amore mio, per tutta la notte ho cercato l’oro. Volevo darti un pegno d’amore… Non ho trovato niente, se non questo pezzo di cesta. Accettalo, così brutto com’è, tanto vicino a te tutto diventa bello.”
Don Pepè rise. “Gente, che minchiate ci fa dire l’amore!”
“Non ridere, Pepè” lo bloccò Rosa, quietamente. “Che non sono lontani i tempi in cui tu per me le minchiate le dicevi a chili!”
Nel frattempo Marastella guardava Turiddu con lo stesso sentimento con cui si guarda un verme contorcersi nella carne putrefatta.
“Ma che felicità ti può dare un pezzo di cesta rotto?” disse. “Porta di meglio, scemo, se vuoi che ti guardi!”
Dopodicché, fece spallucce e tirò dritto per la salita che portava al castello.
“Questa qui non lo saprà mai che cos’è la felicità!” commentò Rosa, scuotendo tristemente la testa.
Anche Ibn Hamdis, da qualche minuto, era uscito fuori a prendere un po’ d’aria mattutina ed aveva guardato la scena dal ballatoio della locanda.
“E per voi, signora, che cos’è la felicità?” chiese.
“Non avere pretese” rispose Rosa. “E capire che già la vita ci basta… e, se non basta, c’è l’intelligenza per farcela bastare.”
Turiddu corse sotto il ballatoio dove stava Ibn Hamdis. “Per tutta la notte ho cercato una cosa preziosa da portare a Marastella…”
“Lascia perdere!” lo interruppe Ibn Hamdis. “Ho avuto modo di vedere il resto.”
Si affacciò, a quel punto, uno dei due compagni del poeta.
“Un giorno” disse l’ultimo arrivato, “alcune galline stavano accovacciate in un cortile, mentre il gallo beccheggiava lì vicino. Ad un certo punto, videro un’aquila, alta nel cielo. Che civetta! disse la gallina più sciocca. Ci passa sopra per far vedere le cosce al nostro gallo! La più saggia, invece, disse: Dio le ali le ha date pure a noi. Non è colpa sua se non sappiamo usarle!”
Turiddu guardò don Pepè. “Questo non parla in poesia, ma sempre a indovinelli la butta!”
“Per dirti la verità…” ammise don Pepè, “neppure io ci ho capito nulla.”
Don Pepè si rivolse all’arabo. “C’è speranza, eccellenza, di capirci qualcosa in quel che avete detto?”
“A Gesù Bambino” disse l’arabo, sorridendo, “io dovrei portare l’omaggio dell’incenso. Con l’incenso il popolo onora i grandi uomini, che sono come le aquile… Volano alti perché sanno usare le ali. Perciò, usa le tue ali e non sprecare il dono di Dio. La ricchezza non è soltanto nell’oro. Trova un oggetto prezioso d’altro tipo, per farne un pegno d’amore!”
Così Rosa A bedda o canali potè continuare il suo racconto in versi:
N’autra notti Turiddu passau fora,
circannu u riàlu ca pariva giustu
pa bedda e capricciusa Marastella…
Prima, tanti scipparru tavuluna!
ci ava jùtu u cchiù riccu picuraru
uffrènnuci i sa pècuri e sa casa,
truvannu pi risposta ca nun basta!
Ci ava jùtu nu mastru muraturi,
purtannuci sei casi e tri palazzi,
truvannu pi risposta ch’era picca!
Ci ava jùtu u cchiù rrossu de viddani,
assemi a centu sarmi di jardinu,
truvannu pi risposta ch’era nenti!
E tannu quannu supra u Carcaruni
pinzava d’ammazzàrisi pa còllira
chiamàu aiùtu e subito i luci-picurari
ci dìssiru: “Chi fai? Nun dispirari!
Semmu cca nui, l’amici di Marianu…
E poi u vidi si u funnu di panaru
ca ci ài nte mani, grazii u nostru incantu,
nun addiventa na cullana d’oru!
L’indomani Turiddu tornò dalla campagna col suo fondo di cesta sfondato, arricchito da pezzi di vetro, grani di sale, pietruzze dai colori più improbabili, sulle quali si muovevano Mariano Coricuntentu, fattosi lucciola, e tante, tante altre lucciole… creando musiche e giochi di luci.
Turiddu, quindi, andò a bussare alla porta di Marastella.
“Stanotte” disse, “ho trovato una cosa più prezio-sa dell’oro: la solidarietà. Mariano Coricuntentu e le sue amiche lucciole mi hanno visto piangere e mi hanno aiutato…”
“Scemo” disse Marastella, dopo avere agguantato quell’ammasso sfilacciato di verghe, “non ci combini nulla con la solidarietà! Le chiacchiere son belle, non dico di no; ma, sta cosa che hai trovato sempre ’na mappata di moscerini resta. Io nella pentola poi che ci butto? Le mosche?”
Quindi, fece spallucce, sapendo bene che così diventava più bella, e si avviò per la salita che portava al castello.
Superata di poco la Locanda del Sogno Antico, si voltò, non nascondendo un’occhiata di antipatia per i tre arabi, che nel frattempo si erano affacciati.
“E non mi fermare più” disse, guardando loro, ma parlando a Turiddu, “che già don Antonino mi ha rimproverata e mi ha detto che, se questa storia continua, verrà lui di persona a parlare… a te e a questi mammelucchi!”
Turiddu non seppe far altro che svenire.
“Ora, per svegliarlo ci vorrebbe il tuo rosòlio!” disse don Pepè a Rosa, chinandosi su Turiddu. “Ma, prendi quello di mandarino, per favore! Pare che sia riuscito meglio!”
“E come no?” esclamò Rosa. “Così, una sucatella gliela dai anche tu.”
“Beh, male non mi farebbe! Mi son preso uno spavento!”
“Gli spaventi me li dai tu, ’mbriacone! Se vedi una bottiglia, non capisci più niente!”
“Eh no, questo non è vero! Bugia! Ogni bottiglia mi ricorda tutte le bottiglie che son venute prima e quelle che ancora devono venire.”
Le strizzò l’occhio. “Lo vedi che capisco?”
A quel punto, il terzo arabo scese dal ballatoio della locanda e si chinò su Turiddu, che nel frattempo era rinvenuto.
“Su, alzati!” gli disse. “Ti consiglio di provare ancora, stanotte!”
“Perché mi dite questo?” esclamò Turiddu. “Perché mi date ancora speranze?”
“Ascoltami! Come dovresti già sapere, io dovrei portare in dono la mirra. Nel mio paese dalla sua corteccia ricaviamo un unguento medicamentoso, per cui essa simboleggia la scienza e l’arte. Ti consiglio, perciò, di cercarla dentro di te, la bellezza. Quella ragazza ha il cuore duro e, quindi, soltanto il suo viso merita l’amore… Impara a scolpirlo nella pietra!”
Rosa A bedda o canali approvò subito.
“Lo so, Turiddu” disse seria. “Ciò che ti ha detto sembra impossibile…”
“Come potrebbe una pietra darmi gli occhi di Ma-rastella?” sospirò il giovane.
“Ah, questo dipende da te!” esclamò don Pepè. “L’artista sei tu… Vediamo! Vediamo che spunta!”
“E che dovrebbe spuntare?”
“A statua, Turiddu, a statua!… Sarà l’unica cosa che resterà di Marastella!” concluse Rosa.